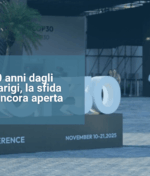Era più o meno una settimana fa, direi il terzo giorno della fase due, il momento del quale tutti noi abbiamo potuto cominciare a circolare di nuovo con maggior libertà. Mi sono svegliato con una sensazione di grandissimo malessere. E’ stato come se, dopo due mesi di autocontrollo e tenuta emotiva nella quale tutte le energie che mentali che avevo erano state dedicate a garantire a me stesso una lucidità comportamentale rispetto a uno stato di cattività anomalo mi fossero franate addosso.
A quanto pare non sono stato l’unico a sperimentare questa situazione. Le evidenze scientifiche e i primi studi confermano che il lockdown ha avuto un particolare impatto sulla psicologia individuale. Avremmo tutti dato un po’ per scontato che questo, purtroppo, avvenisse per chi fosse già affetto da patologie di natura psicologica o psichiatrica. Ciò che non ci saremmo invece aspettati è che, invece, la chiusura collettiva determinasse significativi effetti anche sulle persone che, in una situazione ordinaria, non avevano mai esplicitamente manifestato sintomi di alcun tipo di disequilibrio mentale.
Ma, a quanto pare, è proprio così. La rivista Lancet ha di recente pubblicato sul punto qualche settimana fa un primo risultato di uno studio portato avanti in diversi paesi.
In questa ricerca è stato esaminato l’impatto della pandemia sui comportamenti e sulla salute mentale degli individui. Per effettuarla è stato somministrato un questionario con domande riguardanti sia la salute fisica che altre volte a verificare l’eventuale insorgenza di patologie connesse allo stress ed alla depressione.
La sintesi questo lavoro fa emergere che vi sono sostanzialmente due grandi cluster di impatto di questa pandemia ed identifica effetti sulla tenuta psicologica e mentale delle popolazioni costrette a una situazione di perdita di socialità e di blocco delle relazioni.
L’analisi evidenzia due macro risultati: il primo riguarda l’intera popolazione nella quale si rileva una generale criticità ed aggravamento dei livelli di stress collettivi. Il secondo invece segnala che vi sia stata una significativa insorgenza di effetti psicosociali che hanno colpito la popolazione sanitaria, infermieristica ed in generale coinvolta con il trattamento di malati colpiti da una patologia così grave.
A tali effetti si affianca poi la situazione particolare di bambini ed adolescenti che in questo contesto hanno assolutamente perso la possibilità di interagire fra loro e sono costretti a immaginarsi e costruirsi un’alternativa relazionale basata soltanto su una dimensione virtuale. L’effetto di tutto questo, dicono gli esperti, è un peggioramento dei ritmi di vita ed incremento dell’irritabilità e della paura.
Sul piano personale abbiamo sperimentato tutti in questi mesi la necessità, quasi fisica, di assumere un comportamento responsabile per supportare le scelte istituzionali volte a gestire la riduzione del rischio dello sviluppo della malattia. Dovevamo tutti insieme impedire il collasso delle strutture assistenziali pena il caos totale. So far so good. In qualche modo ci siamo riusciti. Vi sono però degli effetti collaterali di questa attività di contenimento collettiva necessaria ed indispensabile. Oltre i danni economici che ci toccano nel portafoglio in modo evidente, dobbiamo fare i conti con effetti più sottili e profondi di cui dobbiamo assumere consapevolezza. Ansia, paura, difficoltà di superamento dell’attrito di primo distacco per ricominciare a volare. Serve costruire un diverso atteggiamento personale di confronti della modalità di vita che conoscevamo.
Solo una razionale consapevolezza ci può consentire di imparare nuove modalità di azione e di interazione per ricominciare in questa nuova normalità che dovremo affrontare.
Oltre 60 giorni di reclusione domestica rappresentano un’esperienza mai provata per la gran parte degli italiani. Ciascuno di noi ha potuto testare in questa condizione di cattività forzata l’emergere di situazioni personali particolarmente diverse dalla normalità.
Abbiamo sperimentato un cambiamento di comportamenti individuali, una mutazione di abitudini e di attività. Quelle che, in una situazione precedente, venivano vissute attraverso una dimensione sociale sia personale che lavorativa sono semplicemente sparite dal nostro orizzonte.
Ex malo bonum però. Nel suo libro “Capolavori: Allenare, allenarsi, guardare altrove” l’ex allenatore della nazionale maschile di pallavolo Mauro Berruto racconta un episodio particolare quando, nella consapevolezza che avrebbe dovuto affrontare una situazione critica, impose ai suoi giocatori (senza dirglielo) un allenamento all’ingiustizia. Ecco, in qualche modo abbiamo vissuto proprio una esperienza dalla quale trarre una lezione. E qui in qualche modo la valutazione manageriale che ci resta e dalla quale possiamo ripartire.
Quel giorno di una settimana fa avrei potuto rimanere depresso a letto. Ho fatto un’altra scelta. Sono salito sulla mia bicicletta e, rispettando le regole del distanziamento, ho percorso un lunghissimo giro per la mia città. Ho assorbito con gli occhi e il respiro le meraviglie che mi venivano di fronte. Ho potuto apprezzare di nuovo dal vivo la grandezza della storia e della bellezza sconfinata che l’uomo aveva potuto costruire nel corso dei secoli. La maestosità di Roma, della sua storia e della sua grandezza mi venivano incontro.
In quel momento ho ricordato Napoleone che, alla conquista dell’Egitto esortava i suoi uomini con la frase “ Soldats, songez que, du haut de ces Pyramides, quarante siècles vous contemplent”.
Sessanta km di un nuovo inizio: le competenze manageriali e le visioni che dobbiamo mettere in campo escono da qui. Dalle nostre gambe e dalla nostra testa. Occhi nuovi e respiro aperto. E metodo, idee ed execution. E tanto allenamento per sperimentare e confrontarsi con la nuova normalità.
Solo con una grande capacità di visione possiamo immaginare e ricostruire un futuro prossimo nel quale tutto potrà, con fatica, andare meglio.