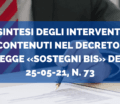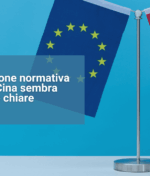L’affermarsi di nuovi modelli di consumo e l’integrazione della strategia di sostenibilità in quella di business impone che l’attività imprenditoriale non sia solo finalizzata al raggiungimento di risultati economici, ma anche al perseguimento di obiettivi ambientali e sociali. A fronte di tale impegno, l’azienda comunica ai propri stakeholder, in modo chiaro e completo, le scelte gestionali e strategiche compiute in ambito economico, sociale e ambientale. La comunicazione tra organizzazione e i vari portatori di interesse avviene attraverso la pubblicazione di una serie di documenti, obbligatori o redatti volontariamente, con i quali si rendiconta l’attività aziendale secondo i principi di trasparenza e responsabilità.
Il Codice civile (artt. da 2423 a 2435bis) rende obbligatorio il bilancio d’esercizio che “deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”. Per quel che concerne le performance socio-ambientali, i due documenti che comunicano gli impatti che l’attività aziendale ha su ambiente e società sono il bilancio ambientale e il bilancio sociale, separati dalla contabilità ordinaria.
L’evoluzione dei due bilanci (sociale e ambientale) è rappresentata dal bilancio di sostenibilità, pubblicato dalle aziende una volta l’anno. Il fine ultimo di tale documento è la rendicontazione degli impatti generati dall’organizzazione sulle dimensioni ambientale e sociale, e l’identificazione di eventuali aree di miglioramento. Il bilancio di sostenibilità, detto anche socio-ambientale, è definito dall’Unione Europea nel Libro verde della Commissione del 2001 come “l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”. In Italia il d.lgs. n. 254/2016 che ha recepito la Direttiva Europea 95/2014 ha reso obbligatoria la rendicontazione non finanziaria per le imprese quotate, del settore bancario assicurativo e per quelle di grandi dimensioni con numero di dipendenti superiore a 500, totale ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 40 milioni di euro, o totale dello stato patrimoniale superiore a 20 milioni di euro. Nonostante ciò, molte imprese decidono di rendicontare le informazioni non finanziarie volontariamente per comunicare in modo trasparente gli impegni assunti in tema di Corporate Social Responsibility (CSR).
Oltre ad assumere valenza nella misurazione e rendicontazione dell’impatto aziendale, il bilancio di sostenibilità, rivolto a tutti gli stakeholder, è utilizzato anche per fini comunicativi, con importanti ripercussioni in termini di brand reputation. I nuovi paradigmi, infatti, sottolineano come la sopravvivenza dell’impresa che prima si basava esclusivamente sul raggiungimento di buone performance economiche, oggi dipenda anche dall’immagine positiva che la stessa riesce ad avere sui propri stakeholder, a fronte delle scelte strategiche e pratiche sostenibili adottate.
Ad oggi non vi sono ancora delle normative vincolanti che obblighino l’utilizzo di un metodo univoco di rendicontazione, ma esistono una serie di linee guida da poter seguire, le più diffuse delle quali sono quelle predisposte dal Global Reporting Initiative (GRI) e condivise a livello internazionale.
Le informazioni relative agli impatti sociali e ambientali dell’attività aziendale sono riportate anche nel bilancio integrato, documento che, seguendo l’approccio “Triple Bottom Line”, sintetizza come la strategia e le performance aziendali permettono la creazione di valore nel breve, medio e lungo termine, in termini di sostenibilità economica, sociale e ambientale. Infatti, nel bilancio integrato confluiscono sia informazioni provenienti propriamente dal bilancio economico (e dunque appartenenti alla dimensione finanziaria), sia informazioni relative alla sfera ambientale e sociale; questa comunicazione sintetica permette agli stakeholder di ottenere informazioni complete e di facile comprensione.
Nel caso di Società Benefit gli amministratori hanno l’obbligo di redigere a cadenza annuale la relazione d’impatto, avente ad oggetto il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio e da pubblicare sul sito web della società, ove esistente. La relazione d’impatto deve contenere:
- la descrizione di obiettivi specifici, modalità e azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune;
- la valutazione dell’impatto generato utilizzando uno standard di valutazione esterno;
- una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.
Lo standard di valutazione esterno deve essere:
1. Esauriente e articolato nel valutare l’impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;
2. Sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa;
3. Credibile perché sviluppato da un ente competente con approccio scientifico;
4. Trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche.
Ne esistono già di internazionali che rappresentano un utile riferimento: B Impact Assessment (BIA), Global Reporting Initiative (GRI) e International Integrated Reporting Council (IIRC).
Join Group che è Società Benefit da ottobre 2020 pubblicherà insieme al bilancio economico la prima Relazione d’impatto, un documento che sempre più assumerà un’importanza strategica all’interno delle attività aziendali. Attraverso questa Relazione Join Group rende conto pubblicamente di cosa ha fatto nei due mesi del primo anno benefit e indica gli obiettivi e i campi di miglioramento che intende perseguire nel prossimo anno.