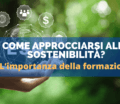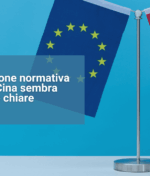L’attenzione alla sostenibilità sta guadagnando sempre più interesse nel panorama finanziario. La finanza sostenibile, seppur con alcune problematiche e incertezze, cerca di porsi come nuovo paradigma per lasciare alle spalle un sistema finanziario oramai non più capace di guadagnarsi la fiducia degli investitori e di affrontare le problematiche odierne. Infatti, la finanza sostenibile propone nuovi strumenti con l’obiettivo di rendere più trasparente il sistema finanziario ed evitare di incorrere in errori passati. Tra questi il rating ESG, che ha l’obiettivo di fornire una valutazione sul grado di compliance dell’operato di un’azienda con le direttive internazionali in materia di sostenibilità. Tuttavia, esso presenta molte problematiche, soprattutto per quanto riguarda il confronto tra le varie valutazioni delle diverse agenzie di rating ESG. Infatti, da una ricerca di Deloitte e dell’ESG European Institute emerge che nei framework di 4 fra in principali provider su un totale di 145 indicatori solo il 15% risultano in comune e, quindi, non sufficienti ad effettuare un confronto.
Nonostante tutto però, gli investitori ESG crescono sempre di più, circa la metà degli investitori istituzionali dichiara di includere i criteri ESG nelle proprie politiche di investimento. Secondo Morningstar circa 2,7 triliardi di dollari sono gestiti da quasi 3.000 fondi ESG. Inoltre, come dichiarato da Bloomberg, gli ETF ESG sono diventati uno dei segmenti di mercato in più rapida crescita, il 55% dei flussi di ETF nel 2022 è andato in ETF ESG.
Per poter farsi strada in questa enorme complessità, generalmente, è possibile riconoscere tre strategie di politiche di investimento ESG utilizzate: il criterio di esclusione, il criterio inclusivo e l’investor-directed approaches.
Il criterio di esclusione consiste nell’escludere dal portafoglio quei titoli appartenenti a settori non conformi ai criteri ESG. Esso può essere adottato secondo l’approccio dello screening normativo o secondo l’approccio di disinvestimento. Lo screening normativo consiste nell’escludere quei titoli non conformi alle norme generali sul tema della sostenibilità fornite dalle istituzioni internazionali come l’OCSE o l’ONU. Il disinvestimento consiste nell’escludere quei titoli appartenenti a settori, che per via delle loro attività produttive, concorrono al cambiamento climatico, come ad esempio il settore dei combustibili fossili. Questa strategia per quanto da una parte permetta di selezionare i titoli “sostenibili”, dall’altra non garantisce una buona diversificazione del portafoglio.
Il criterio di inclusione, invece, consiste nell’includere quei titoli di aziende che manifestano un approccio più attivo verso la sostenibilità, anche se appartenenti a settori non sostenibili. Esso può essere adottato secondo due approcci il Best in class e l’investimento tematico. L’approccio Best in Class tiene conto del rating ESG. L’investitore, quindi, include nel portafoglio titoli appartenenti a tutti i settori, ma con il miglior punteggio ESG. L’investimento tematico consiste nell’includere solo titoli di settori impegnati attivamente nella sostenibilità e che non rechino danno ad essa, come ad esempio il settore delle energie rinnovabili. Entrambi gli approcci permettono all’investitore di diversificare i titoli in portafoglio.
Il criterio Investor-directed approaches si attua attraverso due approcci: l’azionariato attivo e l’impact investing. L’azionariato attivo prevede l’utilizzo dei diritti concessi dal possedimento delle azioni, al fine di influire nelle scelte delle società verso investimenti più sostenibili. L’impact investing, invece, si basa sull’investire in imprese o fondi di investimento che hanno come scopo quello di creare un impatto sociale o ambientale positivo, tenendo conto di un ritorno finanziario.
Tuttavia, definire un investimento sostenibile può risultare ancora complesso, per questo motivo l’Unione Europa sta attuando una serie di normative per la definizione e diffusione degli investimenti sostenibili, come ad esempio la Sustainable Finance Disclosure Regulation o il Regolamento Delegato (UE) 2021/12536.