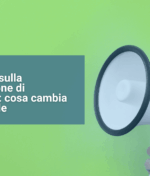Le ultime settimane hanno visto svilupparsi un’importante azione politica e nazionale e comunitaria per la realizzazione di strumenti economici che, se effettivamente messi a terra, potrebbero portare una discontinuità paradigmatica per il nostro sistema economico.
Due grandi momenti di discontinuità.
Parliamo in primo luogo del cosiddetto decreto semplificazioni varato qualche settimana fa dal governo e ora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il secondo pilastro è il grande accordo realizzatosi nelle scorse ore a Bruxelles nel quale, dopo il consiglio europeo più lungo della storia, si determina una importante svolta rispetto ai poteri esercitabili dalla commissione per l’erogazione di risorse economiche in favore degli Stati membri.
Cerchiamo quindi di analizzare i due strumenti che rappresentano l’uno il cosiddetto bazooka economico, l’altro, auspicabilmente, La macchina schiaccia sassi che dovrebbe frapporsi fra i vincoli burocratici della struttura amministrativa pubblica e la effettiva realizzazione di processi più facili a vantaggio delle imprese e dei cittadini.
Partiamo allora da un’analisi di quello che dopo cinque giorni e quattro notti di negoziato alle 5:30 del mattino di martedì scorso ha determinato un accordo su bilancio dell’unione per i prossimi sette anni.
Si è trattato di un accordo definito next generation Eu attraverso il quale distribuire 390 miliardi di euro a fondo perduto ed altri 350 come prestito agli Stati, dai quali l’Europa riparte dopo la pandemia assumendo direttamente su di sé l’onere della fase di sviluppo dell’intera unione.
Il negoziato è stato complesso e ha visto contrapposti pezzi dell’Europa storica contro gli Stati del Nord, in un rimescolamento delle carte e delle alleanze in cui alla fine Germania Francia ed Italia, paesi fondatori dell’Europa, hanno alla fine condotto un negoziato i cui esiti sono senza dubbio positivi.
Come scritto da molti giornali l’Italia sarà il più grande più beneficiario fra gli Stati dell’unione ricevendo nel complesso 209 miliardi, una cifra ben superiore al piano originale della commissione che gliene destinava circa 173.
Certamente un successo negoziale. Ma anche un essenziale vincolo alle riforme e alla ristrutturazione del modello produttivo nazionale.
Vale la pena di ricordare che si è ingaggiata in questi e mesi una fortissima battaglia nei confronti dell’unione e dello strumento di finanziamento del debito Mes. Ciò sulla base di un’affermazione (non tecnicamente sbagliata in verità) per la quale l’Italia non può essere oggetto di un controllo di un condizionamento da parte di altri Stati rispetto all’uso delle risorse che l’unione le mette a disposizione.
La questione è però troppo semplificata e, per questo, tecnicamente mal posta.
Come scritto con chiarezza da parte del professor Mario Monti nel suo fondo sul Corriere della Sera, il tema più che politico è di natura sostanziale. Non è infatti una questione di controlli e di intervento della famigerata e temuta troika. È piuttosto la necessità di assumere la consapevolezza, come già avvenne nel primo dopo guerra con il piano Marshall, che debbono essere rimessi in gioco capacità e competenze per dare vita a una vera e propria ricostruzione.
Come ci ha ricordato Monti, nel dopoguerra furono create organizzazioni infrastrutture volte a supportare il percorso di ripartenza dopo aver visto sui campi di battaglia milioni di morti.
Anche ora con l’accordo di Bruxelles si pongono le condizioni per una nuova ripartenza del XXI secolo.
Le condizioni per l’effettiva realizzazione di questo nuovo scenario sono sostanzialmente le stesse che guidarono l’Italia nel dopo guerra: la necessità improcrastinabile di una modernizzazione non più rimandabile.
E per questo motivo che il secondo strumento del quale proviamo a ragionare ovvero il decreto semplificazioni rappresenta la faccia interna di questo percorso che deve essere necessariamente realizzato. Il provvedimento appena emanato, complesso e articolato e spesso anche molto criptico nella sua scrittura, porta dentro alcune importanti semplificazioni sia sotto il profilo della digitalizzazione che sotto quello delle regole del gioco per poter effettivamente realizzare quelle infrastrutture che servono al paese.
Certo per fare questo servono le competenze, le capacità, la voglia di rimettersi in gioco. Su questo la pubblica amministrazione deve fare passi avanti.
Pensiamo soltanto alla scelta, ribadita anche in questa disposizione, per la quale le responsabilità di project manager e commissariali non vengono valutate e non per il valore che creano. Sono previsti solo modelli di remunerazione flat, senza nessuna parametrazione rispetto al livello di responsabilità che viene attribuita. Questo è certamente un limite che la PA si porta dietro. I livelli di responsabilità non sono tutti uguali. Il manager deve essere pagato e premiato per la sua capacità di decidere. Presto e bene.
Quindi le competenze manageriali dovrebbero essere ancorate alla attività che viene svolta, alle complessità che debbono essere governate, e anche all’effettivo raggiungimento dei risultati.
Sarebbe perciò il caso di immaginare meccanismi anche molto sfidanti che ancorino le retribuzioni dei capi all’effettivo raggiungimento del risultato (su effettivi valori di mercato).
Le competenze sono risorse scarse e dovrebbero essere remunerate per il loro effettivo valore. In una giusta contaminazione pubblico privato.
Le tante risorse che ci sono state destinate dall’accordo europeo sono ovviamente indispensabili per una ripartenza: ma poi le organizzazioni debbono camminare sulle gambe degli uomini e delle donne che le portano avanti.
Non si può non essere rigorosi. Servono scelte di qualità per risorse di qualità. Come nella parabola dei talenti saremo valutati se il molto che ci è stato messo a disposizione sarà fatto fruttare in modo Significativo.
Se lo nascondessimo sotto terra perché abbiamo paura di chi ci ha dato il talento alla fine probabilmente non troveremo neanche quello che avevamo sotterrato. E allora. Come dice la parabola sarebbe solo pianto e stridore di denti.